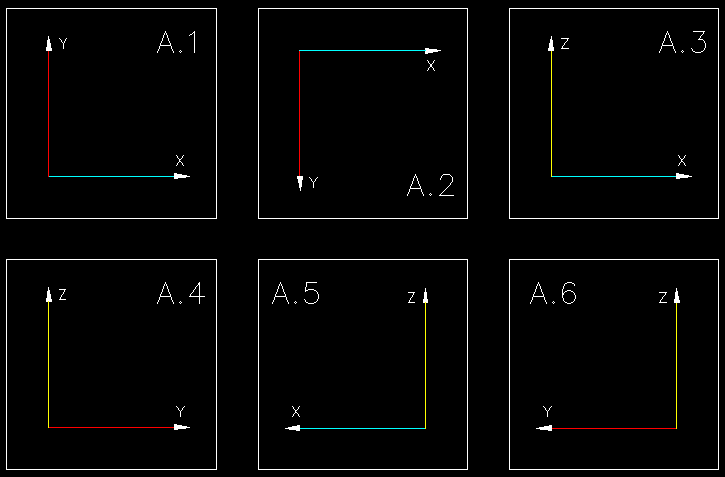
Indicazioni e commenti relativi all'esame scritto di Disegno automatico
del 29 maggio 2000
Camillo Trevisan
I problemi emersi nell'esame scritto del 29 maggio 2000 possono ricondursi a tre diversi temi, equivalenti alle tre ideali sezioni dell'esame.
A) Controllo dello spazio.
L'obiettivo unico di questa sezione è dimostrare la capacità di
riconoscere la giacitura, rispetto agli assi cartesiani, della direzione di
proiezione e del piano di rappresentazione, corrispondenti alle varie proiezioni
di tre versori unitari
posti lungo gli assi cartesiani (gli esercizi si riferiscono tutti a proiezioni
cilindriche).
Il miglior modo per rispondere a tali domande consiste nell'identificare un
oggetto semplice, ma caratterizzato da facce tutte diverse tra loro (come
"l'edificio" di esempio di Cartesio), tracciandone anzitutto la
relativa proiezione.
Inoltre, si dovrà poi identificare la posizione del piano di proiezione e della
direzione principale di proiezione rispetto agli assi cartesiani (esattamente
come illustrato nei grafici posti a destra, sullo schermo di Cartesio),
scegliendo opportunamente la proiezione (o le proiezioni) in modo da
identificare univocamente la configurazione proiettiva data (assi cartesiani,
piano di proiezione, direzione di proiezione).
Infine, è utile definire correttamente il tipo di proiezione: ad esempio, proiezione
assonometrica ortogonale isometrica o proiezione ortogonale su XZ da Y
negativo; oppure, ancora, proiezione assonometrica obliqua dimetrica (scorciamento
in Y pari a 0.5).
Data l'assoluta importanza di questa sezione, essa costituisce oltre un quarto
della valutazione complessiva.
Di seguito alcuni esempi di versori unitari proiettati: la prima immagine si
riferisce a proiezioni ortogonali, la seconda a proiezioni assonometriche
ortogonali isometriche, la terza a proiezioni assonometriche oblique
monometriche e dimetriche (C.3 e C.5).
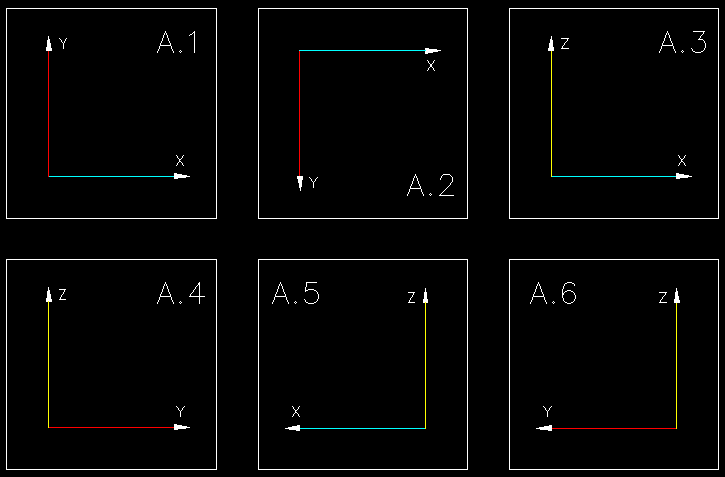
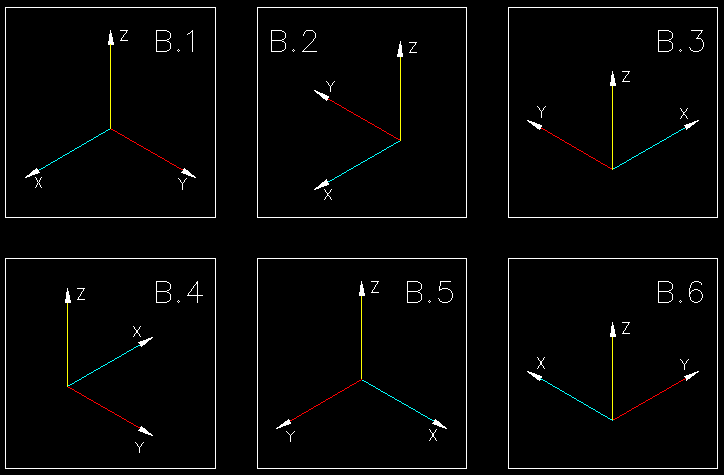
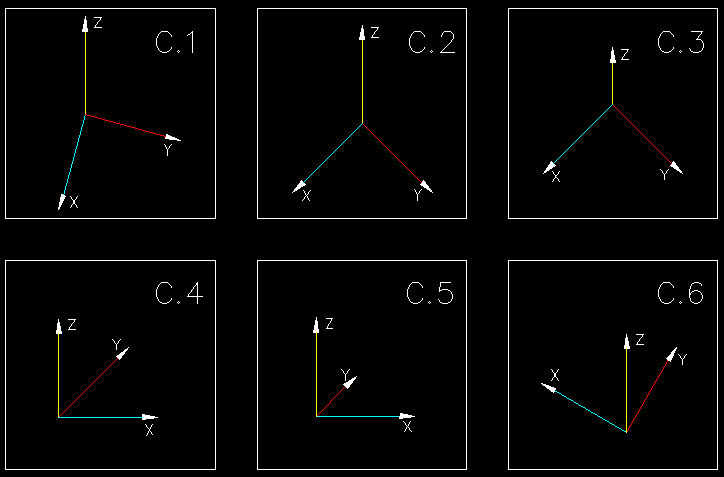
B) Controllo del modello.
Scopo di questa sezione dell'esame è dare la possibilità di dimostrare
la capacità di "leggere" una rappresentazione, comprendere la geometria
del modello e saperla ricostruire per mezzo delle funzioni tipiche della
modellazione solida (non necessariamente legate ad AutoCAD).
Ad esempio, riconoscere l'impossibilità che il cilindro in alto a destra
possa essere stato sezionato, nella parte superiore, da un piano (la
curva di intersezione sarebbe infatti un'ellisse, dunque simmetrica anche
rispetto ad un asse orizzontale); oppure che il modello in basso a destra possa
essere un cilindro cavo (i due segmenti a terra non sarebbero congruenti con
questa ipotesi).
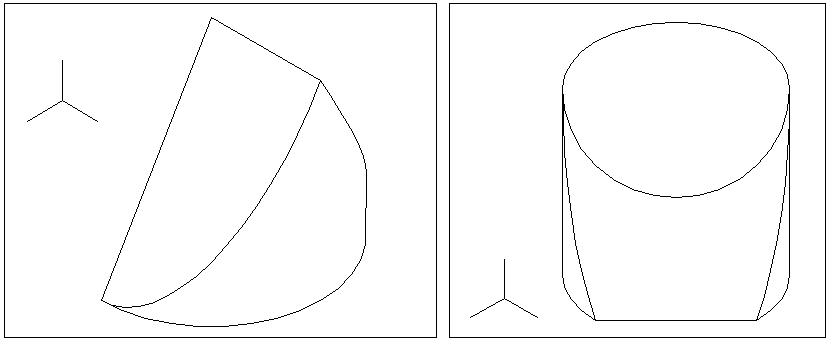
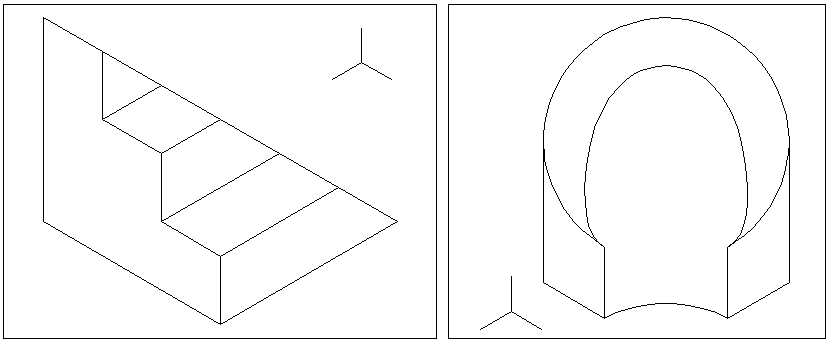
Nell'affrontare questo esercizio, il modo più opportuno di procedere
consiste nell'uso intensivo del disegno (in pianta, prospetti, assonometrie;
usando vari colori e indicando sempre gli assi proiettati), riducendo al minimo la parte descrittiva, anzi eliminandola
quasi del tutto, sostituendola - se necessario - con indicazioni tipiche della
geometria classica.
Ad esempio: rotazione di 90° di ABCDEF attorno
all'asse HL (regola della mano destra), oppure: estrusione di
ABCD lungo EF.
Il risultato finale dovrebbe dunque consistere in una serie coordinata (e
ordinata) di grafici, collegati tra loro da alcune indicazioni formalizzate.
Poiché i solidi proposti sono illustrati mediante un'unica proiezione (in
assonometria ortogonale isometrica), essi potranno spesso essere interpretati in
vari modi: la scelta dell'interpretazione costituisce una parte significativa e
importante dell'esercizio e, pertanto, dovrebbe essere argomentata graficamente
e/o con brevissime frasi di commento.
Questa sezione contribuisce per circa un terzo alla valutazione finale
complessiva.
C) Teoria.
L'ultima sezione dell'esame scritto contiene una decina di domande che
riguardano i vari temi del corso.
Il miglior modo di procedere, anche in questo caso, prevede l'uso intensivo di
grafici (velocemente tracciati a mano libera, meglio se a colori) corredati da
brevi ma significative "didascalie"; oppure identificando i punti
essenziali del tema proposto fornendo per ciascuno di essi una brevissima
descrizione.
La scelta dei punti è, evidentemente, molto significativa, più ancora della
completezza delle risposte.
In altre parole, l'assoluta priorità deve essere data all'inquadramento
generale - ma non generico - del problema: se quest'ultimo non fosse del tutto
chiaro, è conveniente non rispondere affatto alla domanda, concentrando gli
sforzi su altre parti dello scritto.
Ad esempio, alla domanda: Indicare
e commentare brevemente le principali differenze e affinità tra CAD e disegno
‘tradizionale’, una risposta sintetica, non esaustiva ma indicativa, potrebbe essere la
seguente:
| CAD | Disegno "tradizionale" |
| Procedimento ANALITICO | Procedimento ANALOGICO |
| MODELLO "virtuale" dell'oggetto necessariamente completo | RAPPRESENTAZIONE dell'oggetto spesso incompleta e frammentata |
| Modello tridimensionale | Rappresentazione bidimensionale |
| Scala di costruzione del modello 1:1; scala di rappresentazione libera | Scala di costruzione del modello uguale a quella di rappresentazione |
| Libertà di scelta della modalità di rappresentazione | Modalità di rappresentazione fissata a priori |
| Separazione concettuale tra Modello e Rappresentazione | Apparente coincidenza tra Modello e Rappresentazione |
| Introduzione della "quarta dimensione" (il tempo), con possibilità di esplorazione interattiva del modello | Congelamento "istantaneo" della rappresentazione |
| Vicinanza e assonanza con i procedimenti costruttivi reali (in special modo nella modellazione solida) | Rappresentazione ottenuta mediante metodi "astratti" (geometria descrittiva) |
| Strutturazione del modello attraverso insiemi congruenti di "primitive" grafiche | Sostanziale equivalenza di ogni "segno" di uguale spessore e colore |
| Modello prettamente dinamico (libertà e facilità di modifica) | Modello statico (difficoltà di modifica della rappresentazione) |
| Ridondanza | Sinteticità |